Cos’è oggi la Libia? La Libia è la porta del Mediterraneo, un percorso obbligato per raggiungere le coste italiane. E’ soprattutto un lager dove si consumano nei confronti dei migranti efferatezze degne dei peggiori campi di sterminio del XX secolo. Il soggiorno in Libia, per la maggior parte dei profughi africani significa carcere. E il carcere in Libia significa tortura sistematica. I persecutori delle carceri libiche, governative e non, sono bande e organizzazioni criminali, milizie armate, polizia e militari.
L’85% dei migranti ha subito in Libia torture e trattamenti inumani e degradanti: detenzione all’interno di luoghi sovraffollati, tortura da percosse, da elettrodi, da sospensione, falaka, stupri di gruppo.
Dall’inizio del 2017 l’Italia ha avviato una politica di negoziato con i paesi di transito dei migranti, mirante ad arrestare la cosiddetta immigrazione irregolare e a bloccare i flussi migratori attraverso la rotta del mediterraneo centrale. Fanno parte di questo approccio, i finanziamenti concessi dal governo italiano al Mali e al Niger e l’accordo firmato nel febbraio 2017 tra Italia e Libia. Tale accordo è stato concepito in un paese contrassegnato da sistematiche violazioni dei diritti umani estremamente gravi nei confronti dei migranti, commesse dai trafficanti di esseri umani, bande criminali e milizie locali che operano con la connivenza della polizia e della guardia costiera libica stessa. Per i migranti la Libia post-Gheddafi è una grande prigione a cielo aperto, una vasta zona di sfruttamento e di morte. La permanenza al suo interno ha conseguenze drammatiche sulla salute mentale e fisica di un’intera generazione di africani. Dal momento in cui intraprendono il viaggio che li porterà, per forza di cose in Libia, i migranti devono attraversare il deserto affidandosi esclusivamente ai trafficanti e affrontare una serie di abusi, maltrattamenti e violenze.
GLI EFFETTI DEGLI ACCORDI TRA ITALIA E LIBIA
E’ il 2 febbraio 2017 quando viene siglato il memorandum di intesa della Libia con lo stato amico italiano, le firme di Paolo Gentiloni e di Fayez Mustafa Serraj ne suggellano l’intesa. L’accordo asserisce la ferma determinazione di cooperare per individuare soluzioni urgenti alla questione dei migranti clandestini che attraversano la Libia per recarsi in Europa via mare, attraverso la predisposizione dei campi di accoglienza temporanei in Libia, sotto l’esclusivo controllo del Ministero dell’Interno libico, in attesa del rimpatrio o del rientro volontario nei paesi di origine, lavorando al tempo stesso affinché i paesi di origine accettino i propri cittadini ovvero sottoscrivendo con questi paesi accordi in merito. Nello specifico, l’articolo 2 sancisce:
Le Parti si impegnano altresì a intraprendere azioni nei seguenti settori:
1) completamento del sistema di controllo dei confini terrestri del sud della Libia, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del Trattato summenzionato.
2) adeguamento e finanziamento dei centri di accoglienza summenzionati già attivi nel rispetto delle norme pertinenti, usufruendo di finanziamenti disponibili da parte italiana e di finanziamenti dell’Unione Europea. La parte italiana contribuisce, attraverso la fornitura di medicinali e attrezzature mediche per i centri sanitari di accoglienza, a soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria dei migranti illegali, per il trattamento delle malattie trasmissibili e croniche gravi.
3) la formazione del personale libico all’interno dei centri di accoglienza summenzionati per far fronte alle condizioni dei migranti illegali, sostenendo i centri di ricerca libici che operano in questo settore, in modo che possano contribuire all’individuazione dei metodi più adeguati per affrontare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani.
Si tratta, in realtà, di un accordo con chi controlla l’intero sistema dei flussi legale o illegale. La marina libica è autorizzata a intercettare ma non a soccorrere i barconi presenti nelle acque di loro competenza, su segnalazione della Guardia Costiera italiana. I migranti, sfuggiti alle torture e alle violenze all’interno dei campi libici vengono, così bloccati e riportati nelle stesse carceri dalle quali scappavano. Tutto ciò si traduce in un calo del 32% degli sbarchi, sottolineato da Minniti, quale risultato della politica di riduzione degli sbarchi in Italia.
La tortura
Analisi di una pratica sempre attuale ma occulta
L’art. 1 della Convenzione contro la tortura, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, definisce tortura “ogni atto per mezzo del quale un dolore o delle sofferenze acute, sia fisiche che mentali, vengono deliberatamente inflitte a una persona da agenti della pubblica amministrazione o su loro istigazione o comunque da altre persone che agiscono in posizione ufficiale […].
Tale definizione è quella che ha ottenuto il più ampio riconoscimento a livello mondiale: alla fine del 1998 la convenzione è stata ratificata da 122 paesi.
I 3 elementi essenziali che definiscono la tortura:
- Fatti : Sofferenze o dolori fisici o mentali intensi, inflitte intenzionalmente ad una persona.
- Autori : Agenti dello stato o persone agendo a titolo ufficiale o su istigazione delle autorità, con il consenso di esse.
- Scopo : La sofferenza è stata inflitta per uno scopo preciso:
– Estorcere informazioni,
– infliggere punizioni
– Intimidazione
Nonostante sia vietata da numerose convenzioni internazionali, prima fra tutte la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la sua pratica è denunciata in oltre cento paesi nel mondo. Numerosi studi rivelano che almeno il 40% dei richiedenti asilo che vivono in Italia ha subito forme di tortura grave o abusi, il 25% donne, e il 75% uomini, in prevalenza eritrei, somali, afgani, curdi sotto il regime turco e poi centrafricani del Congo, della Costa d’Avorio, della Nigeria. Parecchi quelli che arrivano dalla Libia dopo avere attraversato il deserto. Durante il viaggio spesso vengono fatti oggetto di altri abusi e torture, specie le donne, trattenute e sottoposte a stupri sistematici da bande di predoni che controllano l’accesso nelle regioni di confine. La difficoltà a parlare della pena subita è uno dei lati peggiori della tortura ed è proprio quello che il torturatore cerca di ottenere. Come ogni vera sofferenza questa in particolare è tanto peggiore quanto più è incomunicabile. La persona che ha subito tortura non è portata a parlare di ciò che ha subito perché ha paura, perché parlarne significherebbe rievocare ricordi angosciosi, perché si è convinto che parlarne non serve a niente, perché ha vergogna. La vergogna è un sentimento che appare spesso nei racconti delle vittime di tortura. È un sentimento che si capisce soprattutto dalle descrizioni dei luoghi di prigionia, celle buie, piene di gente, dove si dorme, si mangia, si svolgono le funzioni corporali, sui pavimenti giacciono feriti, morti.
E’ spesso il senso di indistinzione tra i corpi degli individui, dei detenuti, in distinzione tra uomini e animali, tra corpi viventi e resti umani, tra vivi e morti.
Malati per il male ricevuto, percossi sotto le piante dei piedi, ustionati col fuoco o con la corrente elettrica, sospesi al soffitto con gli arti legati, spaccati nelle ossa e distrutti nell’anima. Le conseguenze sul corpo sono devastanti anche in caso di “tecniche psicologiche” di tortura, facendo vivere alla vittima esperienze come l’isolamento per anni, privandola del senso del tempo, in ambienti senza luce o al contrario esponendola a una permanente luce accecante. In alcune circostanze vengono sollecitate volutamente nella vittima esperienze di tipo allucinatorio, così da insinuare lo spettro della follia.
Tra le torture maggiormente praticate in Libia, il primo posto spetta alla Falaka o Falaqa, o Falanga, antica pratica di punizione corporale consistente nella “battitura” delle piante dei piedi, spesso con dei frustini di caucciù, secondo quanto riferiscono i sopravvissuti. Questo tipo di tortura causa il danneggiamento dei talloni, dei tessuti molli del piede, causando dolore e difficoltà nella mobilità, anche a distanza di anni. La “battitura” determina, nell’immediato, un rigonfiamento della pianta del piede oltre che ematomi interni che impediscono la deambulazione per settimane. In tal modo, è più difficile che i prigionieri riescano a scappare dalle carceri prima che il riscatto per la loro liberazione venga pagato.
Altra forma di tortura, particolarmente in auge tra i torturatori libici, è quella della sospensione, a una trave, a un ferro, a dei ganci posti generalmente in alto. A testa in giù, solitamente nudi, mentre gli aguzzini si adoperano nel percuotere violentemente il corpo del detenuto con bastoni, manganelli, fruste, pugni e calci. Dai racconti dei richiedenti asilo in carico all’equipe emerge che anche la tortura da elettrodi è largamente utilizzata in Libia. I cavi elettrici vengono apposti sul corpo del detenuto, generalmente sulla testa, sui genitali o tra le pieghe delle dita. Altre volte vengono costretti a immergersi all’interno di vasche di acqua dove vengono inseriti i cavi di corrente. E poi la più classica delle torture: la violenza sessuale, praticata soprattutto nei confronti delle donne e dei minori.
“Nulla è cambiato.
Il corpo prova dolore,
deve mangiare e respirare e dormire,
ha la pelle sottile, e subito sotto, sangue,
ha una buona scorta di denti e di unghie,
le ossa fragili, le giunture stirabili.
Nelle torture di tutto ciò si tiene conto.

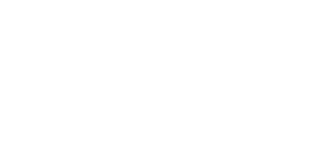

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.